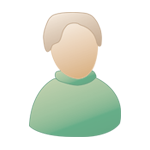PROEMIO
1. La peculiare natura del rito ambrosiano - determinata dall'indole propria della sua tradizione e del suo originale patrimonio, arricchito oggi e riordinato alla luce degli insegnamenti del concilio vaticano II - richiede che si premetta a questo messale una propria "istruzione" generale. Tuttavia i principi dottrinali e molte disposizioni dell'istituzione generale del messale romano, recentemente pubblicato, convengono anche al rinnovato messale del rito ambrosiano e vi si applicano in modo così appropriato che si è giudicato opportuno desumere alla lettera molta parte della medesima "istruzione".
2. Appressandosi a celebrare con i suoi discepoli il banchetto pasquale, nel quale istituì il sacrificio del suo corpo e del suo sangue, Cristo Signore ordinò di preparare una sala grande e addobbata (Lc 22,12). Quest'ordine la Chiesa l'ha sempre considerato rivolto a se stessa, quando dettava le norme per preparare gli animi, disporre i luoghi, fissare i riti e scegliere i testi per la celebrazione dell'eucaristia. Anche le presenti norme, stabilite seguendo le direttive del concilio ecumenico vaticano II, come anche il nuovo messale, che la Chiesa di rito ambrosiano userà d'ora innanzi per celebrare la messa, sono una prova di questa sollecitudine della Chiesa, della sua fede e del suo amore immutato verso il grande mistero eucaristico, e testimoniano la sua continua e ininterrotta tradizione, nonostante vi siano state introdotte alcune novità.
Testimonianza di una fede immutata
3. La natura sacrificale della messa, solennemente affermata dal concilio di Trento (1), in armonia con tutta la tradizione della Chiesa, è stata riaffermata dal concilio vaticano II, che ha pronunziato, a proposito della messa, queste significative parole: "Il nostro Salvatore nell'ultima cena... istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, al fine di perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e di affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione"(2). Questo insegnamento del concilio lo si ritrova costantemente nelle formule della messa. Dice il Sacramentario Leoniano: "Ogni volta che celebriamo il memoriale di questo sacrificio, si compie l'opera della nostra redenzione"(3); ebbene, la dottrina espressa con precisione in questa frase è sviluppata con chiarezza e con cura nelle preghiere eucaristiche: in queste preghiere, quando il sacerdote fa l'anamnesi, rivolgendosi a Dio in nome di tutto il popolo, gli rende grazie e gli offre il sacrificio vivo, santo, cioè l'oblazione della Chiesa e la vittima per la cui immolazione Dio ha voluto essere placato(4), e prega perché il corpo e il sangue di Cristo siano un sacrificio accetto al Padre per la salvezza del mondo intero(5). Così, nel nuovo messale, la regola della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua costante regola di fede; questa ci dice che, fatta eccezione per il modo di offrire, che è differente, vi è piena identità tra il sacrificio della croce e la sua rinnovazione sacramentale nella messa, che Cristo Signore ha istituito nell'ultima cena e ha ordinato agli apostoli di celebrare in memoria di lui; e per conseguenza, la messa è insieme sacrificio di lode, d'azione di grazie, di propiziazione e di espiazione.
4. Anche il mistero mirabile della presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche è affermato dal concilio vaticano II (6) e dagli altri documenti del magistero della Chiesa, (7)nel medesimo senso e con la medesima dottrina con cui il concilio di Trento l'aveva proposto alla nostra fede (Cool. Nella celebrazione della messa, questo mistero è posto in luce non soltanto dalle parole stesse della consacrazione, che rendono il Cristo presente per mezzo della transustanziazione, ma anche dal senso e dall'espressione esterna di sommo rispetto e di adorazione di cui è fatto oggetto nel corso della liturgia eucaristica. Per lo stesso motivo, al giovedì santo e nella solennità del corpo e del sangue del Signore, il popolo cristiano è chiamato a onorare in modo particolare, con l'adorazione, questo ammirabile sacramento.
5. Quanto alla natura del sacerdozio ministeriale, che è proprio del presbitero, in quanto egli offre il sacrificio nella persona di Cristo e presiede l'assemblea del popolo santo, essa è posta in luce, nell'espressione stessa del rito, dal posto eminente del sacerdote e dalla sua funzione. I compiti di questa funzione sono indicati e ribaditi con molta chiarezza nel prefazio della messa crismale del giovedì santo, giorno in cui si commemora l'istituzione del sacerdozio. Il testo sottolinea la potestà sacerdotale conferita per mezzo dell'imposizione delle mani, e descrive questa medesima potestà enumerandone tutti gli uffici: è la continuazione della potestà sacerdotale di Cristo, pontefice sommo della nuova alleanza.
6. Questa natura del sacerdozio ministeriale mette a sua volta nella giusta luce un'altra realtà di grande importanza: il sacerdozio regale dei fedeli, il cui sacrificio spirituale raggiunge la sua perfezione attraverso il ministero dei presbiteri, in unione con il sacrificio di Cristo, unico mediatore (9). La celebrazione dell'eucaristia è infatti azione di tutta la Chiesa; in essa ciascuno compie soltanto, ma integralmente, quello che gli compete, tenuto conto del posto che egli occupa nel popolo di Dio. E' il motivo per cui si presta ora una maggiore attenzione a certi aspetti della celebrazione che, nel corso dei secoli, erano stati talvolta alquanto trascurati. Questo popolo è il popolo di Dio, acquistato dal sangue di Cristo, riunito dal Signore, nutrito con la sua parola; popolo la cui vocazione è di far salire verso Dio le preghiere di tutta la famiglia umana; popolo che, in Cristo, rende grazie per il mistero della salvezza, offrendo il suo sacrificio; popolo infine che, per mezzo della comunione al corpo e al sangue di Cristo, rafforza la sua unità. Questo popolo è già santo per la sua origine; ma in forza della sua partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa al mistero eucaristico, progredisce continuamente in santità (10).
Prova di una tradizione ininterrotta
7. Nell'enunciare le norme per la revisione del rito della messa, il concilio vaticano II ha ordinato, tra l'altro, che certi riti venissero "riportati all'antica tradizione dei santi padri" (11): sono le stesse parole usate da san Pio V nella costituzione apostolica Quo primum, con la quale, nel 1570, promulgava il messale di Trento. In tempi davvero difficili, nei quali la fede cattolica era stata messa in pericolo circa la natura sacrificale della messa, il sacerdozio ministeriale, la presenza reale e permanente di Cristo sotto le specie eucaristiche, a san Pio V premeva anzitutto salvaguardare una tradizione relativamente recente ingiustamente attaccata, introducendo il meno possibile di cambiamenti nel sacro rito. E in verità, il messale del 1570 si differenzia ben poco dal primo messale stampato nel 1474; e questo, a sua volta, riprende fedelmente il messale del tempo di Innocenzo III. Allo stesso modo il messale ambrosiano del 1594 non molto si differenzia dal messale stampato nel 1475, avendo tuttavia attinto non poco dal messale di san Pio V.
8. Attualmente, però, questa "tradizione dei santi padri", che è stata tenuta presente dai revisori responsabili del messale di san Pio V, si è potuta arricchire per l'opera di innumerevoli studi di eruditi. Dopo la prima edizione del sacramentario gregoriano nel 1571, gli antichi sacramentari romani e ambrosiani sono stati oggetto di numerose edizioni critiche; lo stesso si dica degli antichi libri liturgici spagnoli e gallicani. E così il messale ambrosiano del 1609 stampato per ordine del cardinale arcivescovo Federico Borromeo riporta assai fedelmente gli esemplari più antichi; una fedeltà ancora più grande ai testi antichi si ritrova nel messale edito nel 1902 per odine del cardinale arcivescovo Andrea Carlo Ferrari. Tutto questo aveva fatto riscoprire numerose preghiere fino allora ignorate, ma di non poca importanza per la vita dello spirito. Data poi la scoperta di un buon numero di documenti liturgici, sono pure, attualmente, meglio conosciute le tradizioni dei primi secoli, anteriori alla formazione dei riti d'Oriente e d'Occidente. Inoltre, il progresso degli studi patristici ha permesso di appurare la teologia del mistero eucaristico attraverso l'insegnamento di padri eminenti nell'antichità cristiana, come sant'Ireneo, sant'Ambrogio, san Cirillo di Gerusalemme, san Giovanni Crisostomo.
9. La "tradizione dei santi padri" esige dunque che non solo si conservi la tradizione trasmessa dai nostri predecessori immediati, ma che si tenga presente e si approfondisca fin dalle origini tutto il passato della Chiesa e si faccia un'accurata indagine sui modi molteplici con cui l'unica fede si è manifestata in forme di cultura umana e profana così diverse tra loro, quali erano quelle in uso nelle regioni abitate da Semiti, Greci e Latini. Questo approfondimento più vasto ci permette di constatare come lo Spirito santo accordi al popolo di Dio un'ammirevole fedeltà nel conservare immutato il deposito della fede, per grande che sia la varietà delle preghiere e dei riti. In mezzo a questa varietà, il rito ambrosiano "legittimamente riconosciuto e considerato sulla stessa base di diritto e di onore", secondo quanto dice il vaticano II (SC 4), "è stato prudentemente ed integralmente riveduto nello spirito della sana tradizione e gli è stato dato un nuovo vigore, come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo" (12). Le innovazioni apportate al messale romano, attentamente valutate, sono state spesso accolte. Del resto esse più di una volta fanno propria l'antica tradizione ambrosiana, così che lo stesso messale ambrosiano può mutuare parecchio da quello romano, naturalmente salvaguardando ciò che costituisce la peculiare caratteristica della sua originaria tradizione. Mentre infatti alcuni dei principi e delle norme del concilio vaticano II "possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti", le norme di carattere pratico dello stesso concilio "devono intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti" (13).
10. Il nuovo messale, mentre attesta la lex orandi della Chiesa ambrosiana e salvaguarda il deposito della fede trasmesso dai recenti concili, segna a sua volta una tappa di grande importanza nella tradizione liturgica. Quando i padri del concilio vaticano II ripresero le formulazioni dogmatiche del concilio di Trento, le loro parole risuonarono in un'epoca ben diversa nella vita del mondo; è per questo che nel campo pastorale essi hanno potuto dare dei suggerimenti e dei consigli, che sarebbero stati impensabili quattro secoli prima.
11. Il concilio di Trento aveva già riconosciuto il grande valore catechetico contenuto nella celebrazione della messa, ma non poteva trarne tutte le conseguenze pratiche. In realtà si chiedeva da molti che venisse concesso l'uso della lingua volgare nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Ma dinanzi a tale richiesta, il concilio, considerate le circostanze di allora, riteneva suo dovere riaffermare la dottrina tradizionale della Chiesa, secondo la quale il sacrificio eucaristico è anzitutto azione di Cristo stesso: per conseguenza, la sua efficacia non dipende affatto dal modo di partecipazione dei fedeli. Ecco perché si espresse con queste parole decise e misurate insieme: "Benché la messa contenga un ricco insegnamento per il popolo dei fedeli, i padri non hanno ritenuto opportuno, che venga celebrata indistintamente in lingua volgare" (14). E condannò chi osasse affermare che "non si deve ammettere il rito della Chiesa romana, in forza del quale una parte del canone e le parole della consacrazione vengono dette a bassa voce; o che la messa si debba celebrare in lingua volgare" (15). Nondimeno, se da un lato proibì l'uso della lingua parlata nella messa, dall'altro ordinò ai pastori di supplirvi con un'opportuna catechesi: "Perché il gregge di Cristo non soffra la fame... il santo concilio ordina ai pastori e a tutti quelli che hanno cura d'anime di soffermarsi frequentemente, nel corso della celebrazione della messa, o personalmente o per mezzo di altri, su questo o quel testo della messa, e di spiegare, tra l'altro, il mistero di questo santissimo sacrificio, specialmente nelle domeniche e nei giorni festivi" (16).
12. Convocato perché la Chiesa adattasse ai nostri tempi i compiti della sua missione apostolica, il concilio vaticano II ha, come quello di Trento, esaminato profondamente la natura didattica e pastorale della liturgia (17). E poiché non v'è ormai nessun cattolico che neghi la legittimità e l'efficacia del rito compiuto in lingua latina, il concilio ha ammesso senza difficoltà che "l'uso della lingua parlata può riuscire spesso di grande utilità per il popolo" e l'ha quindi permessa (18). L'entusiasmo con cui questa decisione è stata dappertutto accolta, ha portato, sotto la guida dei vescovi e della stessa sede apostolica, alla concessione che tutte le celebrazioni liturgiche con partecipazione di popolo si possono fare in lingua viva, per rendere più facile l'intelligenza piena del mistero celebrato.
13. Tuttavia, poiché l'uso della lingua parlata nella sacra liturgia è soltanto uno strumento, anche se molto importante, per esprimere più chiaramente la catechesi del mistero contenuto nella celebrazione, il concilio vaticano II ha insistito perché si mettessero in pratica certe prescrizioni del concilio di Trento che non erano state dappertutto osservate, come il dovere di fare l'omelia nelle domeniche e nei giorni festivi (19), e la possibilità di intercalare ai riti determinate esortazioni (20). Soprattutto, però, il concilio vaticano II, nel consigliare "quella partecipazione perfetta alla messa, per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore dal medesimo sacrificio" (21), ha portato al compimento di un altro voto dei padri tridentini, che, cioè, per partecipare più pienamente all'eucaristia, "nelle singole messe i presenti si comunicassero non solo con l'intimo fervore dell'anima, ma anche con la recezione sacramentale dell'eucaristia" (22).
14. Indotto dal medesimo spirito e dallo stesso zelo pastorale il concilio vaticano II ha potuto riesaminare le decisioni di Trento a proposito della comunione sotto le due specie. Poiché attualmente nessuno mette in dubbio i principi dottrinali sul pieno valore della comunione sotto la sola specie del pane, il concilio ha permesso in alcuni casi la comunione sotto le due specie, con la quale, grazie a una presentazione più chiara del segno sacramentale, si ha modo di penetrare più profondamente il mistero al quale i fedeli partecipano (23).
15. In questo modo, mentre la Chiesa rimane fedele al suo compito di maestra di verità, conservando "ciò che è vecchio" cioè il deposito della tradizione, assolve pure il suo compito di esaminare e adottare con prudenza "ciò che è nuovo" (cf. Mt 13,52). Una parte del nuovo messale adegua più visibilmente le preghiere della Chiesa ai bisogni del nostro tempo; tali sono specialmente le messe rituali e quelle per "diverse circostanze", nelle quali si fondono felicemente tradizione e novità. Pertanto, mentre sono rimaste intatte molte espressioni attinte alla più antica tradizione della Chiesa e rese familiari dallo stesso messale ambrosiano nelle sue varie edizioni, molte altre sono state adattate alle esigenze e alle condizioni attuali. Altre infine, come le orazioni per la Chiesa, per la santificazione del lavoro umano, per l'unione di tutti i popoli, e per certe necessità proprie del nostro tempo, sono state interamente composte ex novo, traendo i pensieri e spesso anche i termini dai recenti documenti conciliari. Così pure, in vista di una presa di coscienza della situazione nuova del mondo contemporaneo, è sembrato che non si recasse offesa alcuna al venerabile tesoro della tradizione, modificando alcune espressioni dei testi antichi, allo scopo di meglio armonizzare la lingua con quella della teologia attuale e perché esprimessero in verità la presente situazione della disciplina della Chiesa. Per questo motivo sono stati cambiati alcuni modi di esprimersi, che risentivano di una certa mentalità sull'apprezzamento e sull'uso dei beni terrestri, e altri ancora che mettevano in rilievo una forma di penitenza esteriore propria della Chiesa di altri tempi. Le norme liturgiche del concilio di Trento sono state, dunque, su molti punti, completate e integrate dalle norme del concilio vaticano II; il concilio ha così condotto a termine gli sforzi fatti per accostare i fedeli alla liturgia, sforzi condotti per quattro secoli e con più intensità in un'epoca recente, grazie soprattutto allo zelo liturgico promosso da san Pio X e dai suoi successori e, nella Chiesa ambrosiana, dagli arcivescovi A. I. Schuster, G. B. Montini e G. Colombo.
1.Cfr. Concilio Tridentino, Sessione XXII, 17 settembre 1562.
2.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 47; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, nn. 3, 28; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 4,5.
3.Cfr. Sacramentario Veronese, ed. Mohlberg, n. 93.
4.Cfr. Preghiera eucaristica III.
5.Cfr. Preghiera Eucaristica IV.
6.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, nn. 5, 18.
7.Cfr. Pio XII, Lettera enciclica Humani Generis: AAS 42 (1950) pp. 570-571; cfr. Paolo VI, Lettera enciclica Mysterium Fidei, AAS 57 (1965) pp. 762-769; cfr. Solenne professione di fede: AAS 60 (1068) pp. 442-443; cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3f-9: AAS 59 (1967) p. 543-547.
8.Cfr. Concilio Tridentino, Sessione XIII, 11 ottobre 1551.
9.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 2.
10.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 11.
11.Cfr. Ibidem, n. 50.
12.Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 11.
13.Cfr. Ibidem, n. 3.
14.Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 8.
15.Cfr. Ibidem, cap. 9.
16.Cfr. Ibidem, cap. 8.
17.Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 33.
18.Cfr. Ibidem, n. 36.
19.Cfr. Ibidem, n. 52.
20.Cfr. Ibidem, nn. 35, 3.
21.Cfr. Ibidem, n. 55.
22.Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 6.
23.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 55.
CAPITOLO I
Importanza e dignità della celebrazione eucaristica
1. La celebrazione della messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli (1). Nella messa, infatti, si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio (2). In essa inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell'anno, i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo modo presenti (3). Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la messa, da essa derivano e ad essa sono ordinate (4).
2. È perciò di somma importanza che la celebrazione della messa, o cena del Signore, sia ordinata in modo che i ministri e i fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbondanza di quei frutti (5), per il conseguimento del quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua passione e risurrezione, alla Chiesa, sua dilettissima sposa (6).
3. Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea, tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una partecipazione consapevole, attiva e piena, esterna e interna, ardente di fede, speranza e carità; partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo (7).
4. Non sempre si può avere la presenza e l'attiva partecipazione dei fedeli, che manifestano più chiaramente la natura ecclesiale dell'azione liturgica ( ; sempre però la celebrazione eucaristica ha l'efficacia e la dignità che le sono proprie, in quanto è azione di Cristo e della Chiesa (9), e il sacerdote vi agisce sempre per la salvezza del popolo.
; sempre però la celebrazione eucaristica ha l'efficacia e la dignità che le sono proprie, in quanto è azione di Cristo e della Chiesa (9), e il sacerdote vi agisce sempre per la salvezza del popolo.
5. Poiché inoltre la celebrazione dell'eucaristia, come tutta la liturgia, si compie per mezzo di segni sensibili, mediante i quali la fede si alimenta, s'irrobustisce e si esprime (10), si deve avere la massima cura nello scegliere e nel disporre quelle forme e quegli elementi che la Chiesa propone, e che, considerate le circostanze di persone e di luoghi, possono favorire più intensamente la partecipazione attiva e piena e rispondere più adeguatamente al bene dei fedeli.
6. Pertanto questa "istruzione" si propone di esporre i principi generali per l'ordinamento della celebrazione dell'eucaristia, e presentare le norme per regolare le singole forme di celebrazione.
1.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 41; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 11; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 5, 6; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3e, 6: AAS 59 (1967) p. 544-545.
2.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 10.
3.Cfr. Ibidem, n. 102.
4.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 5; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 10.
5.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26, 28, 30.
6.Cfr. Ibidem, n. 47.
7.Cfr. Ibidem, n. 14.
8.Cfr. Ibidem, n. 41.
9.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 13.
10.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 59.
CAPITOLO II
STRUTTURA ELEMENTI E PARTI DELLA MESSA
I. Struttura generale della messa
7. Nella messa o cena del Signore, il popolo di Dio è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdote, che agisce nella persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico (1). Per questa riunione locale della santa Chiesa vale perciò in modo eminente la promessa di Cristo: "Là dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). Infatti nella celebrazione della messa, nella quale si perpetua il sacrificio della croce (2), Cristo è realmente presente nell'assemblea dei fedeli riunita in suo nome, nella persona del ministro, nella sua parola e in modo sostanziale e permanente sotto le specie eucaristiche (3).
8. La messa è costituita da due parti, la "liturgia della parola" e la "liturgia eucaristica"; esse sono così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto (4). Nella messa, infatti, viene imbandita tanto la mensa della parola di Dio quanto la mensa del corpo di Cristo, e i fedeli ne ricevono istruzione e ristoro (5). Ci sono inoltre alcuni riti che iniziano e altri che concludono la celebrazione.
II. Diversi elementi della messa
Lettura della parola e sua spiegazione
9. Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella sua parola, annunzia il vangelo. Per questo, le letture della parola di Dio, che costituiscono un elemento importantissimo della liturgia, si devono ascoltare da tutti con venerazione. E benché la parola di Dio nelle letture della sacra Scrittura sia rivolta a tutti gli uomini di ogni epoca e sia da essi intelligibile, tuttavia la sua efficacia viene accresciuta da un'esposizione viva e attuale, cioè dall'omelia, che è considerata parte dell'azione liturgica (6).
Le orazioni e le altre parti che spettano al sacerdote
10. Tra le parti proprie del sacerdote, occupa il primo posto la preghiera eucaristica, culmine di tutta la celebrazione. Seguono poi le orazioni, cioè: l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica, l'orazione a conclusione della liturgia della parola, l'orazione sui doni e l'orazione dopo la comunione. Queste preghiere, dette dal sacerdote nella sua qualità di presidente dell'assemblea nella persona di Cristo, sono rivolte a Dio a nome dell'intero popolo santo e di tutti i presenti (7). Perciò giustamente si chiamano "orazioni presidenziali".
11. Spetta ugualmente al sacerdote, per il suo ufficio di presidente dell'assemblea radunata, formulare alcune monizioni ( e proporre le formule di introduzione e di conclusione previste nel rito medesimo. Di loro natura queste monizioni non esigono di essere pronunziate alla lettera, nella formulazione presentata nel messale; per cui potrà essere opportuno l'adattarle in qualche modo, almeno in alcuni casi, alle vere condizioni della comunità. Così pure spetta al sacerdote che presiede annunziare la parola di Dio e impartire la benedizione finale. Egli può inoltre intervenire con brevissime parole, all'inizio della celebrazione, per introdurre i fedeli alla messa del giorno; alla liturgia della parola, prima delle letture; alla preghiera eucaristica, prima di iniziare il prefazio; prima del congedo, per concludere l'intera azione sacra.
e proporre le formule di introduzione e di conclusione previste nel rito medesimo. Di loro natura queste monizioni non esigono di essere pronunziate alla lettera, nella formulazione presentata nel messale; per cui potrà essere opportuno l'adattarle in qualche modo, almeno in alcuni casi, alle vere condizioni della comunità. Così pure spetta al sacerdote che presiede annunziare la parola di Dio e impartire la benedizione finale. Egli può inoltre intervenire con brevissime parole, all'inizio della celebrazione, per introdurre i fedeli alla messa del giorno; alla liturgia della parola, prima delle letture; alla preghiera eucaristica, prima di iniziare il prefazio; prima del congedo, per concludere l'intera azione sacra.
12. La natura delle parti "presidenziali" esige che esse siano proferite a voce alta e chiara e che siano ascoltate da tutti con attenzione (9). Perciò mentre il sacerdote le dice, non si devono sovrapporre altre orazioni o canti, e l'organo e altri strumenti musicali devono tacere.
13. Il sacerdote formula preghiere non soltanto come presidente a nome di tutta la comunità, ma talvolta anche a titolo personale, per poter compiere il proprio ministero con maggior attenzione e pietà. Tali preghiere si dicono sottovoce.
Altre formule che ricorrono nella celebrazione
14. Poiché la celebrazione della messa, per sua natura, ha carattere "comunitario" (10), grande rilievo assumono i dialoghi tra il celebrante e l'assemblea dei fedeli, e le acclamazioni (11). Infatti questi elementi non sono soltanto segni esteriori della celebrazione comunitaria, ma favoriscono ed effettuano la comunione tra il sacerdote e il popolo.
15. Le acclamazioni e le risposte dei fedeli al saluto del sacerdote e alle orazioni, costituiscono quel grado di partecipazione attiva che i fedeli riuniti devono porre in atto in ogni forma di messa, per esprimere e ravvivare l'azione di tutta la comunità (12).
16. Altre parti, assai utili per manifestare e favorire la partecipazione attiva dei fedeli, spettano all'intera assemblea; sono soprattutto l'atto penitenziale, la preghiera universale (detta anche preghiera dei fedeli), la professione di fede e la preghiera del Signore (cioè il Padre nostro).
17. Infine, tra le altre formule: a) alcune costituiscono un rito o un atto a sé stante, come l'inno Gloria, il salmo responsoriale, il Simbolo, il Santo (sanctus), l'acclamazione dell'anamnesi e il canto dopo la comunione; b) altre, invece, accompagnano qualche rito, come i canti d'ingresso, dopo il vangelo, di offertorio, quelli che accompagnano la "frazione" del pane e la comunione.
In qual modo proclamare i vari testi
18. Nei testi che devono esser pronunziati a voce alta e chiara dal sacerdote, dai ministri, o da tutti, la voce deve corrispondere al genere del testo, secondo che si tratti di una lettura, di un'orazione, di una monizione, di un'acclamazione, di un canto; deve anche corrispondere alla forma di celebrazione e alla solennità della riunione liturgica. Inoltre si tenga conto delle caratteristiche delle diverse lingue e della cultura specifica di ogni popolo. Nelle rubriche e nelle norme che seguono, le parole "dire" oppure "proclamare" devono essere intese in riferimento sia al canto che alla recita, tenuto conto dei principi sopra esposti.
Importanza del canto
19. I fedeli che si radunano nell'attesa della venuta del loro Signore, sono esortati dall'apostolo a cantare insieme salmi, inni e cantici spirituali (cfr. Col 3,16). Infatti il canto è segno della gioia del cuore (cfr. At 2,46). Perciò dice molto bene sant'Agostino: "Il cantare è proprio di chi ama" (13), e già dall'antichità si formò il detto: "Chi canta bene, prega due volte". Nelle celebrazioni si dia quindi grande importanza al canto, tenuto conto della diversità culturale delle popolazioni e della capacità di ciascun gruppo, anche se non è sempre necessario cantare tutti i testi che per loro natura sono destinati al canto. Nella scelta della parti destinate al canto, si dia la preferenza a quelle di maggior importanza, e soprattutto a quelle che devono essere cantate dal sacerdote o dai ministri con la risposta del popolo, o dal sacerdote e dal popolo insieme (14). Poiché sono sempre più frequenti le riunioni di fedeli di diverse nazionalità, è opportuno che sappiano cantare insieme, in lingua latina, e nelle melodie più facili, almeno le parti dell'ordinario della messa, ma specialmente il Simbolo della fede e la preghiera del Signore (Padre nostro) (15).
Gesti e atteggiamenti del corpo
20. L'atteggiamento comune del corpo, che tutti i partecipanti al rito sono invitati a prendere, è il segno della comunità e dell'unità dell'assemblea: esso esprime e favorisce l'intenzione e i sentimenti dell'animo dei partecipanti (16).
21. Per ottenere l'uniformità nei gesti e negli atteggiamenti, i fedeli seguano le indicazioni che vengono date dal diacono, o dal sacerdote, o da un altro ministro, durante la celebrazione. Inoltre, in tutte le messe, salvo indicazioni in contrario, i fedeli stiano in piedi dall'inizio del canto di ingresso, o mentre il sacerdote si reca all'altare, fino alla conclusione dell'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica compresa; al canto dell'Alleluia prima del vangelo; durante la proclamazione del vangelo; alla preghiera universale (o preghiera dei fedeli); durante la professione di fede e dall'orazione sui doni fino al termine della messa, fatta eccezione di quanto è detto in seguito. Stanno invece seduti durante la proclamazione delle letture prima del vangelo e durante il salmo responsoriale; all'omelia; durante la preparazione dei doni all'offertorio e, se lo si ritiene opportuno, durante il sacro silenzio dopo la comunione. S'inginocchiano poi alla consacrazione, a meno che lo impediscano o la ristrettezza del luogo, o il gran numero dei presenti, o altri motivi ragionevoli. Le comunità più preparate, secondo l'usanza della tradizione ambrosiana, possono inginocchiarsi durante la preghiera universale, seguendo la monizione del diacono o di un ministro idoneo. Inoltre durante il canto o la recita del Padre nostro si possono tenere le braccia allargate: questo gesto, purché opportunamente spiegato, si svolga in un clima fraterno di preghiera.
22. Fra i gesti sono comprese anche le azioni e gli atteggiamenti del sacerdote nel recarsi all'altare, quelle per la presentazione dei doni e per la comunione dei fedeli. Conviene che queste azioni siano fatte in modo decoroso, mentre si eseguono canti appropriati, secondo le norme stabilite per i singoli movimenti.
Il silenzio
23. Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione. La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni (17). Così, durante l'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l'omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di ringraziamento.
III. Le singole parti della messa
A) RITI DI INTRODUZIONE
24. Le parti che precedono la liturgia della parola, cioè l'ingresso, il saluto, l'atto penitenziale, il Gloria e l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica, hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente l'eucaristia.
L'ingresso
25. Quando il popolo è riunito, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con i ministri, si inizia il canto d'ingresso. La funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla celebrazione, favorire l'unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la processione del sacerdote e dei ministri.
26. Il canto viene eseguito dal popolo o dalla schola, oppure dalla schola e dal popolo a cori alternati. Si può utilizzare sia il canto che si trova nell'antifonale, sia quello del messale, oppure un altro canto adatto all'azione sacra, al carattere del giorno o del tempo, e il cui testo sia stato approvato dalla competente autorità. Se all'ingresso non ha luogo il canto, il testo proposto nel messale viene letta o dai fedeli, o da alcuni di essi, o dal lettore, o dal ministro. A questo scopo ci si preoccupi di preparare convenientemente i fedeli. E' meno opportuno infatti che lo reciti il sacerdote stesso. Questa indicazione vale anche per gli altri canti della messa.
Saluto all'altare e al popolo adunato
27. Giunti in presbiterio, il sacerdote e i ministri salutano l'altare. In segno di venerazione, il sacerdote e il diacono lo baciano e il sacerdote lo può incensare secondo l'opportunità.
28. Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e tutta l'assemblea si segnano col segno di croce. Poi il sacerdote con il saluto annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore. Il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata.
29. Salutato il popolo, il sacerdote, o un altro ministro che ne sia capace, può fare una brevissima introduzione alla messa del giorno. Quindi il sacerdote invita all'atto penitenziale, che viene compiuto da tutta la comunità mediante la confessione generale, e si conclude con l'assoluzione del sacerdote. L'atto penitenziale si può tralasciare quando si continua una celebrazione liturgica già iniziata, come nella processione della domenica delle palme, nei funerali, nella processione per la solennità del Titolo o del Patrono e in genere quando si tratta di una vera processione e non di un semplice ingresso. Tranne che nei funerali, in questi casi, molto opportunamente si possono cantare i dodici Kyrie con la sallenda propria o un'antifona appropriata secondo il rito previsto nel Rito della messa.
Gloria in excelsis
30. Il Gloria è un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello. Viene cantato da tutta l'assemblea o dal popolo alternativamente con la schola oppure dalla schola. Se non lo si canta, viene recitato da tutti, insieme o alternativamente. Lo si canta o si recita nelle domeniche fuori del tempo di avvento e quaresima; e inoltre nelle solennità e feste, e in particolari celebrazioni più solenni.
Orazione all'inizio dell'assemblea liturgica
31. Poi il sacerdote invita il popolo a pregare; e tutti insieme con il sacerdote stanno per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e per poter formulare nel proprio cuore la preghiera personale. Quindi il sacerdote dice l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica. Per mezzo di essa viene espresso il carattere della celebrazione e con le parole del sacerdote si rivolge la preghiera a Dio Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito santo. Il popolo, unendosi alla preghiera ed esprimendo il suo assenso, fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen. Nella messa si dice una sola orazione all'inizio dell'assemblea liturgica; la stessa cosa vale anche per l'orazione a conclusione della liturgia della parola, per l'orazione sui doni e per l'orazione dopo la comunione. L'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica termina con la conclusione lunga, e cioè:
- se è rivolta al Padre: Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli;
- se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione si fa menzione del Figlio e non è indicata un'altra conclusione: Egli che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Oppure: Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli;
- se è rivolta al Figlio e non è indicata un'altra conclusione: Tu che sei Dio, e vivi e regni con il Padre, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Invece l'orazione a conclusione della liturgia della parola, l'orazione sui doni e l'orazione dopo la comunione hanno la conclusione breve, e cioè:
- se è rivolta al Padre: Per Cristo nostro Signore;
- se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione medesima si fa menzione del Figlio: Egli vive e regna nei secoli dei secoli;
- se è rivolta al Figlio: Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
B) LITURGIA DELLA PAROLA
32. Le letture scelte dalla Sacra Scrittura con i canti che le accompagnano costituiscono la parte principale della liturgia della parola; l'omelia, il canto dopo il vangelo, la preghiera universale o preghiera dei fedeli e l'orazione a conclusione della liturgia della parola sviluppano e concludono tale parte. Infatti nelle letture, che vengono poi spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo (18), gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente, per mezzo della sua parola, tra i fedeli (19). Il popolo fa propria questa parola divina con i canti; così nutrito, prega nell'orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza del mondo intero.
Le letture bibliche
33. Con le letture si offre ai fedeli la mensa della parola di Dio e si aprono loro i tesori della Bibbia (20). Poiché secondo la tradizione l'ufficio di proclamare le letture non spetta al presidente ma ad uno dei ministri, conviene che, d'ordinario, il diacono, o, in sua assenza, un altro sacerdote legga il vangelo; un lettore invece legga le altre letture. Mancando però il diacono o un altro sacerdote, leggerà il vangelo lo stesso celebrante (21). Secondo la tradizione liturgica ambrosiana, tutti i ministri che proclamano le letture chiedono e ricevono la benedizione del celebrante.
34. Alla lettura del vangelo si deve il massimo rispetto; lo insegna la liturgia stessa, perché la distingue dalle altre letture con particolari onori: sia da parte del ministro incaricato di proclamarla, che si prepara con la benedizione o con la preghiera; sia da parte dei fedeli, i quali con le acclamazioni riconoscono e professano che Cristo è presente e parla a loro, e ascoltano la lettura stando in piedi; sia per mezzo dei segni di venerazione che si rendono al libro dei vangeli.
I canti tra le letture
35. Alla prima lettura segue il salmo responsoriale o salmello, che è parte integrante della liturgia della parola. Il salmo, d'ordinario, è preso dal lezionario, perché ogni testo salmodico è direttamente connesso con la relativa lettura: pertanto la scelta del salmo dipende dalle letture. Nondimeno, perché il popolo più facilmente possa ripetere il ritornello, sono stati scelti alcuni testi comuni di ritornelli e di salmi per diversi tempi dell'anno e per le diverse categorie di santi; questi testi si possono utilizzare al posto di quelli corrispondenti alle letture, ogni volta che il salmo viene cantato. Il cantore del salmo, o salmista, recita (o canta) i versetti del salmo all'ambone o in altro luogo adatto; l'assemblea sta seduta e ascolta, e partecipa di solito con il ritornello, a meno che il salmo non sia recitato (o cantato) o per intero senza ritornello. Se si canta, oltre al salmo designato sul lezionario, si può utilizzare un salmello come sta scritto nell'antifonale.
36. Alla seconda lettura segue l'Alleluia o un altro canto, a seconda del tempo liturgico.
a) L'Alleluia si canta in qualsiasi tempo, tranne che in quaresima. Può essere iniziato o da tutti, o dalla schola, o da un cantore e, se è il caso, lo si ripete. I versetti si scelgono dal lezionario oppure dall'antifonale.
b) L'altro canto è costituito da un versetto prima del vangelo (cioè un canto al vangelo), oppure da un altro salmo o canto come si trovano nel lezionario o nell'antifonale.
37. Quando vi è una sola lettura prima del vangelo:
a) nel tempo in cui si canta l'Alleluia, si può utilizzare o il salmo alleluiatico, oppure il salmo e l'Alleluia con il suo versetto, o solo il salmo o solo l'Alleluia;
b) nel tempo in cui l'Alleluia non si canta, si può eseguire o il salmo, o il versetto prima del vangelo.
38. Il salmo dopo la lettura, se non viene cantato, deve essere detto ad alta voce, invece l'Alleluia e il versetto prima del vangelo, se non si cantano, si possono tralasciare. L'antifona prima del vangelo, che si trova in alcuni giorni determinati (Natale del Signore, Epifania, Pasqua, e solennità del Titolo e del Patrono), se non viene cantata, può essere tralasciata.
L'omelia
39. L'omelia fa parte della liturgia ed è molto raccomandata (22): è infatti necessaria per alimentare la vita cristiana. Deve essere la spiegazione o di qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di un altro testo dell'ordinario o del proprio della messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari necessità di chi ascolta (23).
40. Nelle domeniche e nelle feste di precetto si deve tenere l'omelia in tutte le messe con partecipazione di popolo; in tali giorni, non la si può omettere se non per una causa grave. E' raccomandata negli altri giorni specialmente nelle ferie di avvento, di quaresima e del tempo pasquale; così pure nelle altre feste e circostanze nelle quali è più numeroso il concorso del popolo alla Chiesa (24). L'omelia di solito sia tenuta personalmente dal celebrante.
41. Dopo l'omelia, o anche, secondo l'opportunità, subito dopo la lettura del vangelo, si canta o si recita il canto dopo il vangelo, mentre si prepara l'altare. Durante il canto infatti, l'altare o mensa del Signore, che è il centro di tutta la liturgia eucaristica (25), viene preparato dai ministri in vista della liturgia eucaristica, ponendovi sopra il corporale, il purificatoio e i vasi sacri. Le norme sul modo di eseguire il canto sono le stesse del canto d'ingresso (cfr. n. 26).
Preghiera universale
42. Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale, prega per tutti gli uomini. E' conveniente che nelle messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera, nella quale si elevino suppliche per la santa Chiesa, per i governanti, per coloro che si trovano in necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo (26).
43. La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa:
a) per le necessità della Chiesa;
b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo;
c) per quelli che si trovano in difficoltà;
d) per la comunità locale.
Tuttavia in qualche celebrazione particolare, per esempio nella confermazione e nel matrimonio, la successione delle intenzioni può venire adattata maggiormente alla circostanza particolare.
44. Spetta al sacerdote celebrante guidare la preghiera, invitare, con una breve monizione, i fedeli a pregare, e terminare la preghiera con l'orazione a conclusione della liturgia della parola. Le intenzioni siano proposte da un diacono o da un cantore, o da qualche altra persona (27). Tutta l'assemblea esprime la sua preghiera o con un'invocazione comune, dopo che sono state presentate le intenzioni, oppure pregando in silenzio. Secondo l'antica tradizione ambrosiana, lodevolmente si può usare l'invocazione Kyrie eleison.
Orazione a conclusione della liturgia della parola
45. Terminate le intenzioni della preghiera universale, il sacerdote dice l'orazione a conclusione della liturgia della parola. Essa non va mai omessa, anche quando si tralasciasse la preghiera universale.
C) LITURGIA EUCARISTICA
46. Nell'ultima cena Cristo istituì il sacrificio e convito pasquale per mezzo del quale è reso di continuo presente nella Chiesa il sacrificio della croce, allorché il sacerdote, che rappresenta Cristo Signore, compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo facessero in memoria di lui (28). Cristo infatti prese il pane e il calice, rese grazie, spezzò il pane e li diede ai suoi discepoli, dicendo: "Prendete, mangiate, bevete; questo è il mio corpo; questo è il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me". Perciò la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della liturgia eucaristica in vari momenti, che corrispondono a queste parole e gesti di Cristo. Infatti:
1) Nella preparazione dei doni, vengono portati all'altare pane e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra le sue mani.
2) Nella preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l'opera della salvezza, e le offerte diventano il corpo e il sangue di Cristo.
3) Mediante la frazione di un unico pane si manifesta l'unità dei fedeli, e per mezzo della comunione i fedeli stessi si cibano del corpo e del sangue del Signore, allo stesso modo con il quale gli apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso.
La preparazione dei doni e la professione di fede
47. prima che i doni vengano portati all'altare, secondo l'esortazione evangelica può aver luogo il rito della pace con il quale i fedeli, animati dalla parola di Dio, prima di celebrare il mistero eucaristico si manifestano reciprocamente l'amore fraterno. In tal caso il diacono o, qualora mancasse, il celebrante stesso proclama: Sia pace tra voi o un'altra simile monizione; e tutti si scambiano un segno di pace. La collocazione del rito della pace prima della presentazione dei doni deve essere ritenuta preferenziale rispetto alla collocazione di tale rito prima della comunione.
48. Quindi si portano all'altare i doni, che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo. E' cosa lodevole che i fedeli presentino il pane e il vino; il sacerdote, in luogo opportuno e adatto, li riceve recitando le formule prescritte e i ministri li dispongono sull'altare. Quantunque i fedeli non portino più, come un tempo, il loro proprio pane e vino destinati alla liturgia, tuttavia il rito di presentare questi doni conserva il suo valore e il suo significato spirituale. Si possono anche fare offerte in denaro, o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa, portati dai fedeli o raccolti in Chiesa. Essi vengono deposti in luogo adatto, fuori della mensa eucaristica.
49. Il canto all'offertorio accompagna la processione con la quale si portano i doni; esso si protrae almeno fino a quando i doni sono stati deposti sull'altare. Le norme che regolano questo canto sono le stesse che per il canto d'ingresso (n. 26). L'antifona di offertorio, se non si canta, viene tralasciata.
50. Si può fare l'incensazione dei doni posti sull'altare e dell'altare stesso, per significare che l'offerta della Chiesa e la sua preghiera si innalzano come incenso al cospetto di Dio. Dopo l'incensazione dei doni e dell'altare, anche il sacerdote e il popolo possono ricevere l'incensazione dal diacono o da un altro ministro.
51. Quindi, se è necessario, il sacerdote si lava le mani.
52. Prima di recitare l'orazione sui doni si proclama il Simbolo, con il quale i fedeli prima di celebrare il mistero eucaristico esprimono la loro unica fede nella santissima Trinità.
53. Il simbolo deve essere recitato dal sacerdote insieme con il popolo nelle domeniche; nelle solennità; nei giorni dell'ottava del Natale che prevalgono sulla domenica (26, 27, 28 dicembre); nel sabato in traditione symboli; nei giorni dell'ottava di Pasqua e nelle messe "per i battezzati"; nelle feste del Signore, della beata Vergine Maria, degli apostoli e degli evangelisti; si può dire anche in particolari celebrazioni più solenni. Se viene cantato, si canti normalmente da tutti o a cori alterni.
54. Deposte le offerte sull'altare e compiuti i riti che accompagnano questo gesto, con l'orazione sui doni si conclude la preparazione dei offerte e si prelude alla preghiera eucaristica.
La preghiera eucaristica
55. A questo punto ha inizio il momento centrale e culminante dell'intera celebrazione, vale a dire la preghiera eucaristica, cioè la preghiera di azione di grazie e di santificazione. Il sacerdote invita il popolo a innalzare il cuore verso il Signore nella preghiera e nell'azione di grazie, e lo associa a sé nella solenne preghiera, che egli, a nome di tutta la comunità, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Il significato di questa preghiera è che tutta l'assemblea si unisca insieme con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio.
56. Gli elementi principali di cui consta la preghiera eucaristica, si possono distinguere come segue:
a) L'azione di grazie (che si esprime specialmente nel prefazio): il sacerdote, a nome di tutto il popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l'opera della salvezza o per qualche suo aspetto particolare, a seconda della diversità del giorno, della festa o del tempo.
b) L'acclamazione: tutta l'assemblea, unendosi alle creature celesti, canta o recita il Santo (Sanctus). Questa acclamazione, che fa parte della preghiera eucaristica, è pronunziata da tutto il popolo col sacerdote.
c) L'epiclesi: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza divina, perché i doni offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino il corpo e il sangue di Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno.
d) Il racconto dell'istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di Cristo, si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell'ultima cena, quando offrì il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, lo diede a mangiare e a bere agli apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero.
e) L'anamnesi: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli apostoli, celebra la memoria di Cristo, ricordando soprattutto la sua beata passione, la gloriosa risurrezione e l'ascensione al cielo.
f) L'offerta: nel corso di questa stessa memoria la Chiesa, in modo particolare quella radunata in quel momento e in quel luogo, offre al Padre nello Spirito santo la vittima immacolata. La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma anche imparino ad offrire se stessi e così portino ogni giorno più a compimento, per mezzo di Cristo mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli, perché finalmente Dio sia tutto in tutti (29).
g) Le intercessioni: in esse si esprime che l'eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che terrestre, e che l'offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati a partecipare alla redenzione e alla salvezza acquistata per mezzo del corpo e del sangue di Cristo.
h) La dossologia finale, che esprime la glorificazione di Dio: essa viene ratificata e conclusa con l'acclamazione del popolo. La preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con rispetto e in silenzio, e vi partecipino con le acclamazioni previste nel rito.
Riti di comunione
57. Poiché la celebrazione eucaristica è un convito pasquale, conviene che, secondo il comando del Signore, i fedeli ben disposti ricevano il suo corpo e il suo sangue come cibo spirituale (30). A questo mirano la frazione del pane e gli altri riti preparatori, che dispongono immediatamente i fedeli alla comunione:
a) Il gesto della frazione del pane, compiuto da Cristo nell'ultima cena, sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta l'azione eucaristica. Questo rito non ha soltanto una ragione pratica, ma significa che noi, pur essendo molti, diventiamo un solo corpo nella comunione a un solo pane di vita, che è Cristo (1Cor 10,17).
b) L'immixtio: il celebrante mette nel calice una piccola porzione dell'ostia.
c) Il canto allo spezzare del pane: mentre si compie la frazione del pane e l'immixtio, si canta il canto allo spezzare del pane. Le norme sono le stesse riportate per il canto d'ingresso (cf. n. 26). Come per il canto all'ingresso, se non viene cantato, sia recitato.
d) La preghiera del Signore (o Padre nostro): in essa si chiede il pane quotidiano, nel quale i cristiani scorgono anche un riferimento al pane eucaristico, e si implora la purificazione dei peccati, così che realmente "i santi doni vengano dati ai santi". Il sacerdote rivolge l'invito alla preghiera, che tutti i fedeli dicono insieme con lui; ma soltanto il sacerdote vi aggiunge l'embolismo, che il popolo conclude con la dossologia. L'embolismo, sviluppando l'ultima domanda della preghiera del Signore, chiede per tutta la comunità dei fedeli la liberazione dal potere del male. L'invito (o monizione), la preghiera del Signore, l'embolismo e la dossologia, con la quale il popolo conclude l'embolismo, si cantano o si dicono ad alta voce.
e) In casi particolari, quando si voglia esprimere l'amore vicendevole dei fedeli prima di partecipare all'unico pane, si può collocare a questo punto il rito della pace, omettendolo prima della presentazione dei doni. In ogni caso il sacerdote invoca ugualmente la pace sul popolo dicendo: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
f) La preparazione personale del sacerdote: il celebrante si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il corpo e il sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio.
g) Quindi il celebrante mostra ai fedeli il pane eucaristico che sarà ricevuto nella comunione e li invita al banchetto di Cristo; poi insieme con essi esprime sentimenti di umiltà, servendosi delle parole del vangelo.
h) Si desidera vivamente che i fedeli ricevano il corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa messa, e, nei casi previsti, facciano la comunione al calice, perché anche per mezzo dei segni, la comunione appaia meglio come partecipazione al sacrificio in atto (31).
i) Mentre il sacerdote e i fedeli si comunicano, si esegue il canto di comunione; esso ha lo scopo di esprimere, mediante l'accordo delle voci, l'unione spirituale di coloro che si comunicano, dimostrare la gioia del cuore e rendere più fraterna la processione di coloro che si accostano a ricevere il corpo di Cristo. Il canto comincia mentre il sacerdote si comunica, e si protrae per un certo tempo, durante la comunione dei fedeli. Se però è previsto che dopo la comunione si eseguisca un inno, il canto di comunione s'interrompa al momento opportuno. Come canto di comunione si può utilizzare quello dell'antifonale, con o senza salmo, oppure un altro canto adatto, secondo le norme date per il canto d'ingresso (cfr. n. 26). Se non viene cantato sia recitato.
j) Ultimata la distribuzione della comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità, pregano per un po' di tempo in silenzio. Si può anche far cantare da tutta l'assemblea un inno, un salmo o un altro canto di lode.
k) Nell'orazione dopo la comunione, il sacerdote chiede i frutti del mistero celebrato. Il popolo fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen.
D) RITI DI CONCLUSIONE
58. I riti di conclusione comprendono:
a) Il saluto e la benedizione del sacerdote, che in alcuni giorni e in certe circostanze si può arricchire e sviluppare con un'altra formula più solenne.
b) Il congedo propriamente detto, con il quale si scioglie l'assemblea, perché ognuno ritorni alle sue occupazioni lodando e benedicendo il Signore.
1.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 5; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 33.
2.Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, cap. 1; Cfr. Paolo VI, Solenne professione di fede, 30 giugno 1968, n. 24; AAS 60 (1967) p. 442.
3.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 7; Cfr. Paolo VI, Lettera enciclica Mysterium Fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) p. 764; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 9: AAS 59 (1967) p. 547.
4.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 56; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 10: AAS 59 (1967) p. 547.
5.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 48-51; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Divina rivelazione Dei Verbum, n. 21; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 4.
6.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33, 52.
7.Cfr. Ibidem, n. 33.
8.Cfr. Sacra Congregazione per il Culto Divino, Lettera circolare sulle Preci eucaristiche, 27 aprile 1973, n. 14: AAS 65 (1973) p. 346.
9.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 14: AAS 59 (1967) p. 304.
10.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 26, 27; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 3d: AAS 59 (1967) p. 542.
11.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30.
12.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 16a: AAS 59 (1967) p. 305.
13.Sermo 336,1: PL 38,1472.
14.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, nn. 7, 16: AAS 59 (1967) pp. 302, 305; cfr. Messale Romano, Ordo cantus Missae, ed. tipica 1972, Premesse.
15.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 54; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 59: AAS 56 (1964) p. 891; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam Sacram, 5 marzo 1967, n. 47: AAS 59 (1967) p. 314.
16.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30.
17.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30.
18.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam Sacram, 5 marzo 1967, n. 17: AAS 59 (1967) p. 305.
19.Cfr. Ibidem, n. 7.
20.Cfr. Ibidem, n. 51.
21.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 50: AAS 56 (1964) p. 889.
22.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 52.
23.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 54: AAS 56 (1964) p. 890.
24.Cfr. Ibidem, n. 53.
25.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) p. 898; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) p. 554.
26.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 53.
27.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 56: AAS 56 (1964) p. 890.
28.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 47; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 3a, b: AAS 59 (1967) p. 540-541.
29.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 48; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 5; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 12: AAS 59 (1967) p. 548-549.
30.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Nysterium, 25 maggio 1967, nn. 12, 33a: AAS 59 (1967) pp. 549, 559.
31.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Nysterium, 25 maggio 1967, nn. 31, 32: AAS 59 (1967) pp. 558-559; sulla facoltà di comunicarsi due volte nel medesimo giorno cfr. CIC, can. 917.
1. La peculiare natura del rito ambrosiano - determinata dall'indole propria della sua tradizione e del suo originale patrimonio, arricchito oggi e riordinato alla luce degli insegnamenti del concilio vaticano II - richiede che si premetta a questo messale una propria "istruzione" generale. Tuttavia i principi dottrinali e molte disposizioni dell'istituzione generale del messale romano, recentemente pubblicato, convengono anche al rinnovato messale del rito ambrosiano e vi si applicano in modo così appropriato che si è giudicato opportuno desumere alla lettera molta parte della medesima "istruzione".
2. Appressandosi a celebrare con i suoi discepoli il banchetto pasquale, nel quale istituì il sacrificio del suo corpo e del suo sangue, Cristo Signore ordinò di preparare una sala grande e addobbata (Lc 22,12). Quest'ordine la Chiesa l'ha sempre considerato rivolto a se stessa, quando dettava le norme per preparare gli animi, disporre i luoghi, fissare i riti e scegliere i testi per la celebrazione dell'eucaristia. Anche le presenti norme, stabilite seguendo le direttive del concilio ecumenico vaticano II, come anche il nuovo messale, che la Chiesa di rito ambrosiano userà d'ora innanzi per celebrare la messa, sono una prova di questa sollecitudine della Chiesa, della sua fede e del suo amore immutato verso il grande mistero eucaristico, e testimoniano la sua continua e ininterrotta tradizione, nonostante vi siano state introdotte alcune novità.
Testimonianza di una fede immutata
3. La natura sacrificale della messa, solennemente affermata dal concilio di Trento (1), in armonia con tutta la tradizione della Chiesa, è stata riaffermata dal concilio vaticano II, che ha pronunziato, a proposito della messa, queste significative parole: "Il nostro Salvatore nell'ultima cena... istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, al fine di perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e di affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione"(2). Questo insegnamento del concilio lo si ritrova costantemente nelle formule della messa. Dice il Sacramentario Leoniano: "Ogni volta che celebriamo il memoriale di questo sacrificio, si compie l'opera della nostra redenzione"(3); ebbene, la dottrina espressa con precisione in questa frase è sviluppata con chiarezza e con cura nelle preghiere eucaristiche: in queste preghiere, quando il sacerdote fa l'anamnesi, rivolgendosi a Dio in nome di tutto il popolo, gli rende grazie e gli offre il sacrificio vivo, santo, cioè l'oblazione della Chiesa e la vittima per la cui immolazione Dio ha voluto essere placato(4), e prega perché il corpo e il sangue di Cristo siano un sacrificio accetto al Padre per la salvezza del mondo intero(5). Così, nel nuovo messale, la regola della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua costante regola di fede; questa ci dice che, fatta eccezione per il modo di offrire, che è differente, vi è piena identità tra il sacrificio della croce e la sua rinnovazione sacramentale nella messa, che Cristo Signore ha istituito nell'ultima cena e ha ordinato agli apostoli di celebrare in memoria di lui; e per conseguenza, la messa è insieme sacrificio di lode, d'azione di grazie, di propiziazione e di espiazione.
4. Anche il mistero mirabile della presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche è affermato dal concilio vaticano II (6) e dagli altri documenti del magistero della Chiesa, (7)nel medesimo senso e con la medesima dottrina con cui il concilio di Trento l'aveva proposto alla nostra fede (Cool. Nella celebrazione della messa, questo mistero è posto in luce non soltanto dalle parole stesse della consacrazione, che rendono il Cristo presente per mezzo della transustanziazione, ma anche dal senso e dall'espressione esterna di sommo rispetto e di adorazione di cui è fatto oggetto nel corso della liturgia eucaristica. Per lo stesso motivo, al giovedì santo e nella solennità del corpo e del sangue del Signore, il popolo cristiano è chiamato a onorare in modo particolare, con l'adorazione, questo ammirabile sacramento.
5. Quanto alla natura del sacerdozio ministeriale, che è proprio del presbitero, in quanto egli offre il sacrificio nella persona di Cristo e presiede l'assemblea del popolo santo, essa è posta in luce, nell'espressione stessa del rito, dal posto eminente del sacerdote e dalla sua funzione. I compiti di questa funzione sono indicati e ribaditi con molta chiarezza nel prefazio della messa crismale del giovedì santo, giorno in cui si commemora l'istituzione del sacerdozio. Il testo sottolinea la potestà sacerdotale conferita per mezzo dell'imposizione delle mani, e descrive questa medesima potestà enumerandone tutti gli uffici: è la continuazione della potestà sacerdotale di Cristo, pontefice sommo della nuova alleanza.
6. Questa natura del sacerdozio ministeriale mette a sua volta nella giusta luce un'altra realtà di grande importanza: il sacerdozio regale dei fedeli, il cui sacrificio spirituale raggiunge la sua perfezione attraverso il ministero dei presbiteri, in unione con il sacrificio di Cristo, unico mediatore (9). La celebrazione dell'eucaristia è infatti azione di tutta la Chiesa; in essa ciascuno compie soltanto, ma integralmente, quello che gli compete, tenuto conto del posto che egli occupa nel popolo di Dio. E' il motivo per cui si presta ora una maggiore attenzione a certi aspetti della celebrazione che, nel corso dei secoli, erano stati talvolta alquanto trascurati. Questo popolo è il popolo di Dio, acquistato dal sangue di Cristo, riunito dal Signore, nutrito con la sua parola; popolo la cui vocazione è di far salire verso Dio le preghiere di tutta la famiglia umana; popolo che, in Cristo, rende grazie per il mistero della salvezza, offrendo il suo sacrificio; popolo infine che, per mezzo della comunione al corpo e al sangue di Cristo, rafforza la sua unità. Questo popolo è già santo per la sua origine; ma in forza della sua partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa al mistero eucaristico, progredisce continuamente in santità (10).
Prova di una tradizione ininterrotta
7. Nell'enunciare le norme per la revisione del rito della messa, il concilio vaticano II ha ordinato, tra l'altro, che certi riti venissero "riportati all'antica tradizione dei santi padri" (11): sono le stesse parole usate da san Pio V nella costituzione apostolica Quo primum, con la quale, nel 1570, promulgava il messale di Trento. In tempi davvero difficili, nei quali la fede cattolica era stata messa in pericolo circa la natura sacrificale della messa, il sacerdozio ministeriale, la presenza reale e permanente di Cristo sotto le specie eucaristiche, a san Pio V premeva anzitutto salvaguardare una tradizione relativamente recente ingiustamente attaccata, introducendo il meno possibile di cambiamenti nel sacro rito. E in verità, il messale del 1570 si differenzia ben poco dal primo messale stampato nel 1474; e questo, a sua volta, riprende fedelmente il messale del tempo di Innocenzo III. Allo stesso modo il messale ambrosiano del 1594 non molto si differenzia dal messale stampato nel 1475, avendo tuttavia attinto non poco dal messale di san Pio V.
8. Attualmente, però, questa "tradizione dei santi padri", che è stata tenuta presente dai revisori responsabili del messale di san Pio V, si è potuta arricchire per l'opera di innumerevoli studi di eruditi. Dopo la prima edizione del sacramentario gregoriano nel 1571, gli antichi sacramentari romani e ambrosiani sono stati oggetto di numerose edizioni critiche; lo stesso si dica degli antichi libri liturgici spagnoli e gallicani. E così il messale ambrosiano del 1609 stampato per ordine del cardinale arcivescovo Federico Borromeo riporta assai fedelmente gli esemplari più antichi; una fedeltà ancora più grande ai testi antichi si ritrova nel messale edito nel 1902 per odine del cardinale arcivescovo Andrea Carlo Ferrari. Tutto questo aveva fatto riscoprire numerose preghiere fino allora ignorate, ma di non poca importanza per la vita dello spirito. Data poi la scoperta di un buon numero di documenti liturgici, sono pure, attualmente, meglio conosciute le tradizioni dei primi secoli, anteriori alla formazione dei riti d'Oriente e d'Occidente. Inoltre, il progresso degli studi patristici ha permesso di appurare la teologia del mistero eucaristico attraverso l'insegnamento di padri eminenti nell'antichità cristiana, come sant'Ireneo, sant'Ambrogio, san Cirillo di Gerusalemme, san Giovanni Crisostomo.
9. La "tradizione dei santi padri" esige dunque che non solo si conservi la tradizione trasmessa dai nostri predecessori immediati, ma che si tenga presente e si approfondisca fin dalle origini tutto il passato della Chiesa e si faccia un'accurata indagine sui modi molteplici con cui l'unica fede si è manifestata in forme di cultura umana e profana così diverse tra loro, quali erano quelle in uso nelle regioni abitate da Semiti, Greci e Latini. Questo approfondimento più vasto ci permette di constatare come lo Spirito santo accordi al popolo di Dio un'ammirevole fedeltà nel conservare immutato il deposito della fede, per grande che sia la varietà delle preghiere e dei riti. In mezzo a questa varietà, il rito ambrosiano "legittimamente riconosciuto e considerato sulla stessa base di diritto e di onore", secondo quanto dice il vaticano II (SC 4), "è stato prudentemente ed integralmente riveduto nello spirito della sana tradizione e gli è stato dato un nuovo vigore, come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo" (12). Le innovazioni apportate al messale romano, attentamente valutate, sono state spesso accolte. Del resto esse più di una volta fanno propria l'antica tradizione ambrosiana, così che lo stesso messale ambrosiano può mutuare parecchio da quello romano, naturalmente salvaguardando ciò che costituisce la peculiare caratteristica della sua originaria tradizione. Mentre infatti alcuni dei principi e delle norme del concilio vaticano II "possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti", le norme di carattere pratico dello stesso concilio "devono intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti" (13).
10. Il nuovo messale, mentre attesta la lex orandi della Chiesa ambrosiana e salvaguarda il deposito della fede trasmesso dai recenti concili, segna a sua volta una tappa di grande importanza nella tradizione liturgica. Quando i padri del concilio vaticano II ripresero le formulazioni dogmatiche del concilio di Trento, le loro parole risuonarono in un'epoca ben diversa nella vita del mondo; è per questo che nel campo pastorale essi hanno potuto dare dei suggerimenti e dei consigli, che sarebbero stati impensabili quattro secoli prima.
11. Il concilio di Trento aveva già riconosciuto il grande valore catechetico contenuto nella celebrazione della messa, ma non poteva trarne tutte le conseguenze pratiche. In realtà si chiedeva da molti che venisse concesso l'uso della lingua volgare nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Ma dinanzi a tale richiesta, il concilio, considerate le circostanze di allora, riteneva suo dovere riaffermare la dottrina tradizionale della Chiesa, secondo la quale il sacrificio eucaristico è anzitutto azione di Cristo stesso: per conseguenza, la sua efficacia non dipende affatto dal modo di partecipazione dei fedeli. Ecco perché si espresse con queste parole decise e misurate insieme: "Benché la messa contenga un ricco insegnamento per il popolo dei fedeli, i padri non hanno ritenuto opportuno, che venga celebrata indistintamente in lingua volgare" (14). E condannò chi osasse affermare che "non si deve ammettere il rito della Chiesa romana, in forza del quale una parte del canone e le parole della consacrazione vengono dette a bassa voce; o che la messa si debba celebrare in lingua volgare" (15). Nondimeno, se da un lato proibì l'uso della lingua parlata nella messa, dall'altro ordinò ai pastori di supplirvi con un'opportuna catechesi: "Perché il gregge di Cristo non soffra la fame... il santo concilio ordina ai pastori e a tutti quelli che hanno cura d'anime di soffermarsi frequentemente, nel corso della celebrazione della messa, o personalmente o per mezzo di altri, su questo o quel testo della messa, e di spiegare, tra l'altro, il mistero di questo santissimo sacrificio, specialmente nelle domeniche e nei giorni festivi" (16).
12. Convocato perché la Chiesa adattasse ai nostri tempi i compiti della sua missione apostolica, il concilio vaticano II ha, come quello di Trento, esaminato profondamente la natura didattica e pastorale della liturgia (17). E poiché non v'è ormai nessun cattolico che neghi la legittimità e l'efficacia del rito compiuto in lingua latina, il concilio ha ammesso senza difficoltà che "l'uso della lingua parlata può riuscire spesso di grande utilità per il popolo" e l'ha quindi permessa (18). L'entusiasmo con cui questa decisione è stata dappertutto accolta, ha portato, sotto la guida dei vescovi e della stessa sede apostolica, alla concessione che tutte le celebrazioni liturgiche con partecipazione di popolo si possono fare in lingua viva, per rendere più facile l'intelligenza piena del mistero celebrato.
13. Tuttavia, poiché l'uso della lingua parlata nella sacra liturgia è soltanto uno strumento, anche se molto importante, per esprimere più chiaramente la catechesi del mistero contenuto nella celebrazione, il concilio vaticano II ha insistito perché si mettessero in pratica certe prescrizioni del concilio di Trento che non erano state dappertutto osservate, come il dovere di fare l'omelia nelle domeniche e nei giorni festivi (19), e la possibilità di intercalare ai riti determinate esortazioni (20). Soprattutto, però, il concilio vaticano II, nel consigliare "quella partecipazione perfetta alla messa, per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore dal medesimo sacrificio" (21), ha portato al compimento di un altro voto dei padri tridentini, che, cioè, per partecipare più pienamente all'eucaristia, "nelle singole messe i presenti si comunicassero non solo con l'intimo fervore dell'anima, ma anche con la recezione sacramentale dell'eucaristia" (22).
14. Indotto dal medesimo spirito e dallo stesso zelo pastorale il concilio vaticano II ha potuto riesaminare le decisioni di Trento a proposito della comunione sotto le due specie. Poiché attualmente nessuno mette in dubbio i principi dottrinali sul pieno valore della comunione sotto la sola specie del pane, il concilio ha permesso in alcuni casi la comunione sotto le due specie, con la quale, grazie a una presentazione più chiara del segno sacramentale, si ha modo di penetrare più profondamente il mistero al quale i fedeli partecipano (23).
15. In questo modo, mentre la Chiesa rimane fedele al suo compito di maestra di verità, conservando "ciò che è vecchio" cioè il deposito della tradizione, assolve pure il suo compito di esaminare e adottare con prudenza "ciò che è nuovo" (cf. Mt 13,52). Una parte del nuovo messale adegua più visibilmente le preghiere della Chiesa ai bisogni del nostro tempo; tali sono specialmente le messe rituali e quelle per "diverse circostanze", nelle quali si fondono felicemente tradizione e novità. Pertanto, mentre sono rimaste intatte molte espressioni attinte alla più antica tradizione della Chiesa e rese familiari dallo stesso messale ambrosiano nelle sue varie edizioni, molte altre sono state adattate alle esigenze e alle condizioni attuali. Altre infine, come le orazioni per la Chiesa, per la santificazione del lavoro umano, per l'unione di tutti i popoli, e per certe necessità proprie del nostro tempo, sono state interamente composte ex novo, traendo i pensieri e spesso anche i termini dai recenti documenti conciliari. Così pure, in vista di una presa di coscienza della situazione nuova del mondo contemporaneo, è sembrato che non si recasse offesa alcuna al venerabile tesoro della tradizione, modificando alcune espressioni dei testi antichi, allo scopo di meglio armonizzare la lingua con quella della teologia attuale e perché esprimessero in verità la presente situazione della disciplina della Chiesa. Per questo motivo sono stati cambiati alcuni modi di esprimersi, che risentivano di una certa mentalità sull'apprezzamento e sull'uso dei beni terrestri, e altri ancora che mettevano in rilievo una forma di penitenza esteriore propria della Chiesa di altri tempi. Le norme liturgiche del concilio di Trento sono state, dunque, su molti punti, completate e integrate dalle norme del concilio vaticano II; il concilio ha così condotto a termine gli sforzi fatti per accostare i fedeli alla liturgia, sforzi condotti per quattro secoli e con più intensità in un'epoca recente, grazie soprattutto allo zelo liturgico promosso da san Pio X e dai suoi successori e, nella Chiesa ambrosiana, dagli arcivescovi A. I. Schuster, G. B. Montini e G. Colombo.
1.Cfr. Concilio Tridentino, Sessione XXII, 17 settembre 1562.
2.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 47; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, nn. 3, 28; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 4,5.
3.Cfr. Sacramentario Veronese, ed. Mohlberg, n. 93.
4.Cfr. Preghiera eucaristica III.
5.Cfr. Preghiera Eucaristica IV.
6.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, nn. 5, 18.
7.Cfr. Pio XII, Lettera enciclica Humani Generis: AAS 42 (1950) pp. 570-571; cfr. Paolo VI, Lettera enciclica Mysterium Fidei, AAS 57 (1965) pp. 762-769; cfr. Solenne professione di fede: AAS 60 (1068) pp. 442-443; cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3f-9: AAS 59 (1967) p. 543-547.
8.Cfr. Concilio Tridentino, Sessione XIII, 11 ottobre 1551.
9.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 2.
10.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 11.
11.Cfr. Ibidem, n. 50.
12.Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 11.
13.Cfr. Ibidem, n. 3.
14.Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 8.
15.Cfr. Ibidem, cap. 9.
16.Cfr. Ibidem, cap. 8.
17.Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 33.
18.Cfr. Ibidem, n. 36.
19.Cfr. Ibidem, n. 52.
20.Cfr. Ibidem, nn. 35, 3.
21.Cfr. Ibidem, n. 55.
22.Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 6.
23.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 55.
CAPITOLO I
Importanza e dignità della celebrazione eucaristica
1. La celebrazione della messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli (1). Nella messa, infatti, si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio (2). In essa inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell'anno, i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo modo presenti (3). Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la messa, da essa derivano e ad essa sono ordinate (4).
2. È perciò di somma importanza che la celebrazione della messa, o cena del Signore, sia ordinata in modo che i ministri e i fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbondanza di quei frutti (5), per il conseguimento del quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua passione e risurrezione, alla Chiesa, sua dilettissima sposa (6).
3. Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea, tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una partecipazione consapevole, attiva e piena, esterna e interna, ardente di fede, speranza e carità; partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo (7).
4. Non sempre si può avere la presenza e l'attiva partecipazione dei fedeli, che manifestano più chiaramente la natura ecclesiale dell'azione liturgica (
5. Poiché inoltre la celebrazione dell'eucaristia, come tutta la liturgia, si compie per mezzo di segni sensibili, mediante i quali la fede si alimenta, s'irrobustisce e si esprime (10), si deve avere la massima cura nello scegliere e nel disporre quelle forme e quegli elementi che la Chiesa propone, e che, considerate le circostanze di persone e di luoghi, possono favorire più intensamente la partecipazione attiva e piena e rispondere più adeguatamente al bene dei fedeli.
6. Pertanto questa "istruzione" si propone di esporre i principi generali per l'ordinamento della celebrazione dell'eucaristia, e presentare le norme per regolare le singole forme di celebrazione.
1.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 41; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 11; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 5, 6; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3e, 6: AAS 59 (1967) p. 544-545.
2.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 10.
3.Cfr. Ibidem, n. 102.
4.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 5; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 10.
5.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26, 28, 30.
6.Cfr. Ibidem, n. 47.
7.Cfr. Ibidem, n. 14.
8.Cfr. Ibidem, n. 41.
9.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 13.
10.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 59.
CAPITOLO II
STRUTTURA ELEMENTI E PARTI DELLA MESSA
I. Struttura generale della messa
7. Nella messa o cena del Signore, il popolo di Dio è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdote, che agisce nella persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico (1). Per questa riunione locale della santa Chiesa vale perciò in modo eminente la promessa di Cristo: "Là dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). Infatti nella celebrazione della messa, nella quale si perpetua il sacrificio della croce (2), Cristo è realmente presente nell'assemblea dei fedeli riunita in suo nome, nella persona del ministro, nella sua parola e in modo sostanziale e permanente sotto le specie eucaristiche (3).
8. La messa è costituita da due parti, la "liturgia della parola" e la "liturgia eucaristica"; esse sono così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto (4). Nella messa, infatti, viene imbandita tanto la mensa della parola di Dio quanto la mensa del corpo di Cristo, e i fedeli ne ricevono istruzione e ristoro (5). Ci sono inoltre alcuni riti che iniziano e altri che concludono la celebrazione.
II. Diversi elementi della messa
Lettura della parola e sua spiegazione
9. Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella sua parola, annunzia il vangelo. Per questo, le letture della parola di Dio, che costituiscono un elemento importantissimo della liturgia, si devono ascoltare da tutti con venerazione. E benché la parola di Dio nelle letture della sacra Scrittura sia rivolta a tutti gli uomini di ogni epoca e sia da essi intelligibile, tuttavia la sua efficacia viene accresciuta da un'esposizione viva e attuale, cioè dall'omelia, che è considerata parte dell'azione liturgica (6).
Le orazioni e le altre parti che spettano al sacerdote
10. Tra le parti proprie del sacerdote, occupa il primo posto la preghiera eucaristica, culmine di tutta la celebrazione. Seguono poi le orazioni, cioè: l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica, l'orazione a conclusione della liturgia della parola, l'orazione sui doni e l'orazione dopo la comunione. Queste preghiere, dette dal sacerdote nella sua qualità di presidente dell'assemblea nella persona di Cristo, sono rivolte a Dio a nome dell'intero popolo santo e di tutti i presenti (7). Perciò giustamente si chiamano "orazioni presidenziali".
11. Spetta ugualmente al sacerdote, per il suo ufficio di presidente dell'assemblea radunata, formulare alcune monizioni (
12. La natura delle parti "presidenziali" esige che esse siano proferite a voce alta e chiara e che siano ascoltate da tutti con attenzione (9). Perciò mentre il sacerdote le dice, non si devono sovrapporre altre orazioni o canti, e l'organo e altri strumenti musicali devono tacere.
13. Il sacerdote formula preghiere non soltanto come presidente a nome di tutta la comunità, ma talvolta anche a titolo personale, per poter compiere il proprio ministero con maggior attenzione e pietà. Tali preghiere si dicono sottovoce.
Altre formule che ricorrono nella celebrazione
14. Poiché la celebrazione della messa, per sua natura, ha carattere "comunitario" (10), grande rilievo assumono i dialoghi tra il celebrante e l'assemblea dei fedeli, e le acclamazioni (11). Infatti questi elementi non sono soltanto segni esteriori della celebrazione comunitaria, ma favoriscono ed effettuano la comunione tra il sacerdote e il popolo.
15. Le acclamazioni e le risposte dei fedeli al saluto del sacerdote e alle orazioni, costituiscono quel grado di partecipazione attiva che i fedeli riuniti devono porre in atto in ogni forma di messa, per esprimere e ravvivare l'azione di tutta la comunità (12).
16. Altre parti, assai utili per manifestare e favorire la partecipazione attiva dei fedeli, spettano all'intera assemblea; sono soprattutto l'atto penitenziale, la preghiera universale (detta anche preghiera dei fedeli), la professione di fede e la preghiera del Signore (cioè il Padre nostro).
17. Infine, tra le altre formule: a) alcune costituiscono un rito o un atto a sé stante, come l'inno Gloria, il salmo responsoriale, il Simbolo, il Santo (sanctus), l'acclamazione dell'anamnesi e il canto dopo la comunione; b) altre, invece, accompagnano qualche rito, come i canti d'ingresso, dopo il vangelo, di offertorio, quelli che accompagnano la "frazione" del pane e la comunione.
In qual modo proclamare i vari testi
18. Nei testi che devono esser pronunziati a voce alta e chiara dal sacerdote, dai ministri, o da tutti, la voce deve corrispondere al genere del testo, secondo che si tratti di una lettura, di un'orazione, di una monizione, di un'acclamazione, di un canto; deve anche corrispondere alla forma di celebrazione e alla solennità della riunione liturgica. Inoltre si tenga conto delle caratteristiche delle diverse lingue e della cultura specifica di ogni popolo. Nelle rubriche e nelle norme che seguono, le parole "dire" oppure "proclamare" devono essere intese in riferimento sia al canto che alla recita, tenuto conto dei principi sopra esposti.
Importanza del canto
19. I fedeli che si radunano nell'attesa della venuta del loro Signore, sono esortati dall'apostolo a cantare insieme salmi, inni e cantici spirituali (cfr. Col 3,16). Infatti il canto è segno della gioia del cuore (cfr. At 2,46). Perciò dice molto bene sant'Agostino: "Il cantare è proprio di chi ama" (13), e già dall'antichità si formò il detto: "Chi canta bene, prega due volte". Nelle celebrazioni si dia quindi grande importanza al canto, tenuto conto della diversità culturale delle popolazioni e della capacità di ciascun gruppo, anche se non è sempre necessario cantare tutti i testi che per loro natura sono destinati al canto. Nella scelta della parti destinate al canto, si dia la preferenza a quelle di maggior importanza, e soprattutto a quelle che devono essere cantate dal sacerdote o dai ministri con la risposta del popolo, o dal sacerdote e dal popolo insieme (14). Poiché sono sempre più frequenti le riunioni di fedeli di diverse nazionalità, è opportuno che sappiano cantare insieme, in lingua latina, e nelle melodie più facili, almeno le parti dell'ordinario della messa, ma specialmente il Simbolo della fede e la preghiera del Signore (Padre nostro) (15).
Gesti e atteggiamenti del corpo
20. L'atteggiamento comune del corpo, che tutti i partecipanti al rito sono invitati a prendere, è il segno della comunità e dell'unità dell'assemblea: esso esprime e favorisce l'intenzione e i sentimenti dell'animo dei partecipanti (16).
21. Per ottenere l'uniformità nei gesti e negli atteggiamenti, i fedeli seguano le indicazioni che vengono date dal diacono, o dal sacerdote, o da un altro ministro, durante la celebrazione. Inoltre, in tutte le messe, salvo indicazioni in contrario, i fedeli stiano in piedi dall'inizio del canto di ingresso, o mentre il sacerdote si reca all'altare, fino alla conclusione dell'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica compresa; al canto dell'Alleluia prima del vangelo; durante la proclamazione del vangelo; alla preghiera universale (o preghiera dei fedeli); durante la professione di fede e dall'orazione sui doni fino al termine della messa, fatta eccezione di quanto è detto in seguito. Stanno invece seduti durante la proclamazione delle letture prima del vangelo e durante il salmo responsoriale; all'omelia; durante la preparazione dei doni all'offertorio e, se lo si ritiene opportuno, durante il sacro silenzio dopo la comunione. S'inginocchiano poi alla consacrazione, a meno che lo impediscano o la ristrettezza del luogo, o il gran numero dei presenti, o altri motivi ragionevoli. Le comunità più preparate, secondo l'usanza della tradizione ambrosiana, possono inginocchiarsi durante la preghiera universale, seguendo la monizione del diacono o di un ministro idoneo. Inoltre durante il canto o la recita del Padre nostro si possono tenere le braccia allargate: questo gesto, purché opportunamente spiegato, si svolga in un clima fraterno di preghiera.
22. Fra i gesti sono comprese anche le azioni e gli atteggiamenti del sacerdote nel recarsi all'altare, quelle per la presentazione dei doni e per la comunione dei fedeli. Conviene che queste azioni siano fatte in modo decoroso, mentre si eseguono canti appropriati, secondo le norme stabilite per i singoli movimenti.
Il silenzio
23. Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione. La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni (17). Così, durante l'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l'omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di ringraziamento.
III. Le singole parti della messa
A) RITI DI INTRODUZIONE
24. Le parti che precedono la liturgia della parola, cioè l'ingresso, il saluto, l'atto penitenziale, il Gloria e l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica, hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente l'eucaristia.
L'ingresso
25. Quando il popolo è riunito, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con i ministri, si inizia il canto d'ingresso. La funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla celebrazione, favorire l'unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la processione del sacerdote e dei ministri.
26. Il canto viene eseguito dal popolo o dalla schola, oppure dalla schola e dal popolo a cori alternati. Si può utilizzare sia il canto che si trova nell'antifonale, sia quello del messale, oppure un altro canto adatto all'azione sacra, al carattere del giorno o del tempo, e il cui testo sia stato approvato dalla competente autorità. Se all'ingresso non ha luogo il canto, il testo proposto nel messale viene letta o dai fedeli, o da alcuni di essi, o dal lettore, o dal ministro. A questo scopo ci si preoccupi di preparare convenientemente i fedeli. E' meno opportuno infatti che lo reciti il sacerdote stesso. Questa indicazione vale anche per gli altri canti della messa.
Saluto all'altare e al popolo adunato
27. Giunti in presbiterio, il sacerdote e i ministri salutano l'altare. In segno di venerazione, il sacerdote e il diacono lo baciano e il sacerdote lo può incensare secondo l'opportunità.
28. Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e tutta l'assemblea si segnano col segno di croce. Poi il sacerdote con il saluto annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore. Il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata.
29. Salutato il popolo, il sacerdote, o un altro ministro che ne sia capace, può fare una brevissima introduzione alla messa del giorno. Quindi il sacerdote invita all'atto penitenziale, che viene compiuto da tutta la comunità mediante la confessione generale, e si conclude con l'assoluzione del sacerdote. L'atto penitenziale si può tralasciare quando si continua una celebrazione liturgica già iniziata, come nella processione della domenica delle palme, nei funerali, nella processione per la solennità del Titolo o del Patrono e in genere quando si tratta di una vera processione e non di un semplice ingresso. Tranne che nei funerali, in questi casi, molto opportunamente si possono cantare i dodici Kyrie con la sallenda propria o un'antifona appropriata secondo il rito previsto nel Rito della messa.
Gloria in excelsis
30. Il Gloria è un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello. Viene cantato da tutta l'assemblea o dal popolo alternativamente con la schola oppure dalla schola. Se non lo si canta, viene recitato da tutti, insieme o alternativamente. Lo si canta o si recita nelle domeniche fuori del tempo di avvento e quaresima; e inoltre nelle solennità e feste, e in particolari celebrazioni più solenni.
Orazione all'inizio dell'assemblea liturgica
31. Poi il sacerdote invita il popolo a pregare; e tutti insieme con il sacerdote stanno per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e per poter formulare nel proprio cuore la preghiera personale. Quindi il sacerdote dice l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica. Per mezzo di essa viene espresso il carattere della celebrazione e con le parole del sacerdote si rivolge la preghiera a Dio Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito santo. Il popolo, unendosi alla preghiera ed esprimendo il suo assenso, fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen. Nella messa si dice una sola orazione all'inizio dell'assemblea liturgica; la stessa cosa vale anche per l'orazione a conclusione della liturgia della parola, per l'orazione sui doni e per l'orazione dopo la comunione. L'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica termina con la conclusione lunga, e cioè:
- se è rivolta al Padre: Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli;
- se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione si fa menzione del Figlio e non è indicata un'altra conclusione: Egli che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Oppure: Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli;
- se è rivolta al Figlio e non è indicata un'altra conclusione: Tu che sei Dio, e vivi e regni con il Padre, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Invece l'orazione a conclusione della liturgia della parola, l'orazione sui doni e l'orazione dopo la comunione hanno la conclusione breve, e cioè:
- se è rivolta al Padre: Per Cristo nostro Signore;
- se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione medesima si fa menzione del Figlio: Egli vive e regna nei secoli dei secoli;
- se è rivolta al Figlio: Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
B) LITURGIA DELLA PAROLA
32. Le letture scelte dalla Sacra Scrittura con i canti che le accompagnano costituiscono la parte principale della liturgia della parola; l'omelia, il canto dopo il vangelo, la preghiera universale o preghiera dei fedeli e l'orazione a conclusione della liturgia della parola sviluppano e concludono tale parte. Infatti nelle letture, che vengono poi spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo (18), gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente, per mezzo della sua parola, tra i fedeli (19). Il popolo fa propria questa parola divina con i canti; così nutrito, prega nell'orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza del mondo intero.
Le letture bibliche
33. Con le letture si offre ai fedeli la mensa della parola di Dio e si aprono loro i tesori della Bibbia (20). Poiché secondo la tradizione l'ufficio di proclamare le letture non spetta al presidente ma ad uno dei ministri, conviene che, d'ordinario, il diacono, o, in sua assenza, un altro sacerdote legga il vangelo; un lettore invece legga le altre letture. Mancando però il diacono o un altro sacerdote, leggerà il vangelo lo stesso celebrante (21). Secondo la tradizione liturgica ambrosiana, tutti i ministri che proclamano le letture chiedono e ricevono la benedizione del celebrante.
34. Alla lettura del vangelo si deve il massimo rispetto; lo insegna la liturgia stessa, perché la distingue dalle altre letture con particolari onori: sia da parte del ministro incaricato di proclamarla, che si prepara con la benedizione o con la preghiera; sia da parte dei fedeli, i quali con le acclamazioni riconoscono e professano che Cristo è presente e parla a loro, e ascoltano la lettura stando in piedi; sia per mezzo dei segni di venerazione che si rendono al libro dei vangeli.
I canti tra le letture
35. Alla prima lettura segue il salmo responsoriale o salmello, che è parte integrante della liturgia della parola. Il salmo, d'ordinario, è preso dal lezionario, perché ogni testo salmodico è direttamente connesso con la relativa lettura: pertanto la scelta del salmo dipende dalle letture. Nondimeno, perché il popolo più facilmente possa ripetere il ritornello, sono stati scelti alcuni testi comuni di ritornelli e di salmi per diversi tempi dell'anno e per le diverse categorie di santi; questi testi si possono utilizzare al posto di quelli corrispondenti alle letture, ogni volta che il salmo viene cantato. Il cantore del salmo, o salmista, recita (o canta) i versetti del salmo all'ambone o in altro luogo adatto; l'assemblea sta seduta e ascolta, e partecipa di solito con il ritornello, a meno che il salmo non sia recitato (o cantato) o per intero senza ritornello. Se si canta, oltre al salmo designato sul lezionario, si può utilizzare un salmello come sta scritto nell'antifonale.
36. Alla seconda lettura segue l'Alleluia o un altro canto, a seconda del tempo liturgico.
a) L'Alleluia si canta in qualsiasi tempo, tranne che in quaresima. Può essere iniziato o da tutti, o dalla schola, o da un cantore e, se è il caso, lo si ripete. I versetti si scelgono dal lezionario oppure dall'antifonale.
b) L'altro canto è costituito da un versetto prima del vangelo (cioè un canto al vangelo), oppure da un altro salmo o canto come si trovano nel lezionario o nell'antifonale.
37. Quando vi è una sola lettura prima del vangelo:
a) nel tempo in cui si canta l'Alleluia, si può utilizzare o il salmo alleluiatico, oppure il salmo e l'Alleluia con il suo versetto, o solo il salmo o solo l'Alleluia;
b) nel tempo in cui l'Alleluia non si canta, si può eseguire o il salmo, o il versetto prima del vangelo.
38. Il salmo dopo la lettura, se non viene cantato, deve essere detto ad alta voce, invece l'Alleluia e il versetto prima del vangelo, se non si cantano, si possono tralasciare. L'antifona prima del vangelo, che si trova in alcuni giorni determinati (Natale del Signore, Epifania, Pasqua, e solennità del Titolo e del Patrono), se non viene cantata, può essere tralasciata.
L'omelia
39. L'omelia fa parte della liturgia ed è molto raccomandata (22): è infatti necessaria per alimentare la vita cristiana. Deve essere la spiegazione o di qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di un altro testo dell'ordinario o del proprio della messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari necessità di chi ascolta (23).
40. Nelle domeniche e nelle feste di precetto si deve tenere l'omelia in tutte le messe con partecipazione di popolo; in tali giorni, non la si può omettere se non per una causa grave. E' raccomandata negli altri giorni specialmente nelle ferie di avvento, di quaresima e del tempo pasquale; così pure nelle altre feste e circostanze nelle quali è più numeroso il concorso del popolo alla Chiesa (24). L'omelia di solito sia tenuta personalmente dal celebrante.
41. Dopo l'omelia, o anche, secondo l'opportunità, subito dopo la lettura del vangelo, si canta o si recita il canto dopo il vangelo, mentre si prepara l'altare. Durante il canto infatti, l'altare o mensa del Signore, che è il centro di tutta la liturgia eucaristica (25), viene preparato dai ministri in vista della liturgia eucaristica, ponendovi sopra il corporale, il purificatoio e i vasi sacri. Le norme sul modo di eseguire il canto sono le stesse del canto d'ingresso (cfr. n. 26).
Preghiera universale
42. Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale, prega per tutti gli uomini. E' conveniente che nelle messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera, nella quale si elevino suppliche per la santa Chiesa, per i governanti, per coloro che si trovano in necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo (26).
43. La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa:
a) per le necessità della Chiesa;
b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo;
c) per quelli che si trovano in difficoltà;
d) per la comunità locale.
Tuttavia in qualche celebrazione particolare, per esempio nella confermazione e nel matrimonio, la successione delle intenzioni può venire adattata maggiormente alla circostanza particolare.
44. Spetta al sacerdote celebrante guidare la preghiera, invitare, con una breve monizione, i fedeli a pregare, e terminare la preghiera con l'orazione a conclusione della liturgia della parola. Le intenzioni siano proposte da un diacono o da un cantore, o da qualche altra persona (27). Tutta l'assemblea esprime la sua preghiera o con un'invocazione comune, dopo che sono state presentate le intenzioni, oppure pregando in silenzio. Secondo l'antica tradizione ambrosiana, lodevolmente si può usare l'invocazione Kyrie eleison.
Orazione a conclusione della liturgia della parola
45. Terminate le intenzioni della preghiera universale, il sacerdote dice l'orazione a conclusione della liturgia della parola. Essa non va mai omessa, anche quando si tralasciasse la preghiera universale.
C) LITURGIA EUCARISTICA
46. Nell'ultima cena Cristo istituì il sacrificio e convito pasquale per mezzo del quale è reso di continuo presente nella Chiesa il sacrificio della croce, allorché il sacerdote, che rappresenta Cristo Signore, compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo facessero in memoria di lui (28). Cristo infatti prese il pane e il calice, rese grazie, spezzò il pane e li diede ai suoi discepoli, dicendo: "Prendete, mangiate, bevete; questo è il mio corpo; questo è il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me". Perciò la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della liturgia eucaristica in vari momenti, che corrispondono a queste parole e gesti di Cristo. Infatti:
1) Nella preparazione dei doni, vengono portati all'altare pane e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra le sue mani.
2) Nella preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l'opera della salvezza, e le offerte diventano il corpo e il sangue di Cristo.
3) Mediante la frazione di un unico pane si manifesta l'unità dei fedeli, e per mezzo della comunione i fedeli stessi si cibano del corpo e del sangue del Signore, allo stesso modo con il quale gli apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso.
La preparazione dei doni e la professione di fede
47. prima che i doni vengano portati all'altare, secondo l'esortazione evangelica può aver luogo il rito della pace con il quale i fedeli, animati dalla parola di Dio, prima di celebrare il mistero eucaristico si manifestano reciprocamente l'amore fraterno. In tal caso il diacono o, qualora mancasse, il celebrante stesso proclama: Sia pace tra voi o un'altra simile monizione; e tutti si scambiano un segno di pace. La collocazione del rito della pace prima della presentazione dei doni deve essere ritenuta preferenziale rispetto alla collocazione di tale rito prima della comunione.
48. Quindi si portano all'altare i doni, che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo. E' cosa lodevole che i fedeli presentino il pane e il vino; il sacerdote, in luogo opportuno e adatto, li riceve recitando le formule prescritte e i ministri li dispongono sull'altare. Quantunque i fedeli non portino più, come un tempo, il loro proprio pane e vino destinati alla liturgia, tuttavia il rito di presentare questi doni conserva il suo valore e il suo significato spirituale. Si possono anche fare offerte in denaro, o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa, portati dai fedeli o raccolti in Chiesa. Essi vengono deposti in luogo adatto, fuori della mensa eucaristica.
49. Il canto all'offertorio accompagna la processione con la quale si portano i doni; esso si protrae almeno fino a quando i doni sono stati deposti sull'altare. Le norme che regolano questo canto sono le stesse che per il canto d'ingresso (n. 26). L'antifona di offertorio, se non si canta, viene tralasciata.
50. Si può fare l'incensazione dei doni posti sull'altare e dell'altare stesso, per significare che l'offerta della Chiesa e la sua preghiera si innalzano come incenso al cospetto di Dio. Dopo l'incensazione dei doni e dell'altare, anche il sacerdote e il popolo possono ricevere l'incensazione dal diacono o da un altro ministro.
51. Quindi, se è necessario, il sacerdote si lava le mani.
52. Prima di recitare l'orazione sui doni si proclama il Simbolo, con il quale i fedeli prima di celebrare il mistero eucaristico esprimono la loro unica fede nella santissima Trinità.
53. Il simbolo deve essere recitato dal sacerdote insieme con il popolo nelle domeniche; nelle solennità; nei giorni dell'ottava del Natale che prevalgono sulla domenica (26, 27, 28 dicembre); nel sabato in traditione symboli; nei giorni dell'ottava di Pasqua e nelle messe "per i battezzati"; nelle feste del Signore, della beata Vergine Maria, degli apostoli e degli evangelisti; si può dire anche in particolari celebrazioni più solenni. Se viene cantato, si canti normalmente da tutti o a cori alterni.
54. Deposte le offerte sull'altare e compiuti i riti che accompagnano questo gesto, con l'orazione sui doni si conclude la preparazione dei offerte e si prelude alla preghiera eucaristica.
La preghiera eucaristica
55. A questo punto ha inizio il momento centrale e culminante dell'intera celebrazione, vale a dire la preghiera eucaristica, cioè la preghiera di azione di grazie e di santificazione. Il sacerdote invita il popolo a innalzare il cuore verso il Signore nella preghiera e nell'azione di grazie, e lo associa a sé nella solenne preghiera, che egli, a nome di tutta la comunità, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Il significato di questa preghiera è che tutta l'assemblea si unisca insieme con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio.
56. Gli elementi principali di cui consta la preghiera eucaristica, si possono distinguere come segue:
a) L'azione di grazie (che si esprime specialmente nel prefazio): il sacerdote, a nome di tutto il popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l'opera della salvezza o per qualche suo aspetto particolare, a seconda della diversità del giorno, della festa o del tempo.
b) L'acclamazione: tutta l'assemblea, unendosi alle creature celesti, canta o recita il Santo (Sanctus). Questa acclamazione, che fa parte della preghiera eucaristica, è pronunziata da tutto il popolo col sacerdote.
c) L'epiclesi: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza divina, perché i doni offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino il corpo e il sangue di Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno.
d) Il racconto dell'istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di Cristo, si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell'ultima cena, quando offrì il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, lo diede a mangiare e a bere agli apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero.
e) L'anamnesi: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli apostoli, celebra la memoria di Cristo, ricordando soprattutto la sua beata passione, la gloriosa risurrezione e l'ascensione al cielo.
f) L'offerta: nel corso di questa stessa memoria la Chiesa, in modo particolare quella radunata in quel momento e in quel luogo, offre al Padre nello Spirito santo la vittima immacolata. La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma anche imparino ad offrire se stessi e così portino ogni giorno più a compimento, per mezzo di Cristo mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli, perché finalmente Dio sia tutto in tutti (29).
g) Le intercessioni: in esse si esprime che l'eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che terrestre, e che l'offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati a partecipare alla redenzione e alla salvezza acquistata per mezzo del corpo e del sangue di Cristo.
h) La dossologia finale, che esprime la glorificazione di Dio: essa viene ratificata e conclusa con l'acclamazione del popolo. La preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con rispetto e in silenzio, e vi partecipino con le acclamazioni previste nel rito.
Riti di comunione
57. Poiché la celebrazione eucaristica è un convito pasquale, conviene che, secondo il comando del Signore, i fedeli ben disposti ricevano il suo corpo e il suo sangue come cibo spirituale (30). A questo mirano la frazione del pane e gli altri riti preparatori, che dispongono immediatamente i fedeli alla comunione:
a) Il gesto della frazione del pane, compiuto da Cristo nell'ultima cena, sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta l'azione eucaristica. Questo rito non ha soltanto una ragione pratica, ma significa che noi, pur essendo molti, diventiamo un solo corpo nella comunione a un solo pane di vita, che è Cristo (1Cor 10,17).
b) L'immixtio: il celebrante mette nel calice una piccola porzione dell'ostia.
c) Il canto allo spezzare del pane: mentre si compie la frazione del pane e l'immixtio, si canta il canto allo spezzare del pane. Le norme sono le stesse riportate per il canto d'ingresso (cf. n. 26). Come per il canto all'ingresso, se non viene cantato, sia recitato.
d) La preghiera del Signore (o Padre nostro): in essa si chiede il pane quotidiano, nel quale i cristiani scorgono anche un riferimento al pane eucaristico, e si implora la purificazione dei peccati, così che realmente "i santi doni vengano dati ai santi". Il sacerdote rivolge l'invito alla preghiera, che tutti i fedeli dicono insieme con lui; ma soltanto il sacerdote vi aggiunge l'embolismo, che il popolo conclude con la dossologia. L'embolismo, sviluppando l'ultima domanda della preghiera del Signore, chiede per tutta la comunità dei fedeli la liberazione dal potere del male. L'invito (o monizione), la preghiera del Signore, l'embolismo e la dossologia, con la quale il popolo conclude l'embolismo, si cantano o si dicono ad alta voce.
e) In casi particolari, quando si voglia esprimere l'amore vicendevole dei fedeli prima di partecipare all'unico pane, si può collocare a questo punto il rito della pace, omettendolo prima della presentazione dei doni. In ogni caso il sacerdote invoca ugualmente la pace sul popolo dicendo: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
f) La preparazione personale del sacerdote: il celebrante si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il corpo e il sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio.
g) Quindi il celebrante mostra ai fedeli il pane eucaristico che sarà ricevuto nella comunione e li invita al banchetto di Cristo; poi insieme con essi esprime sentimenti di umiltà, servendosi delle parole del vangelo.
h) Si desidera vivamente che i fedeli ricevano il corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa messa, e, nei casi previsti, facciano la comunione al calice, perché anche per mezzo dei segni, la comunione appaia meglio come partecipazione al sacrificio in atto (31).
i) Mentre il sacerdote e i fedeli si comunicano, si esegue il canto di comunione; esso ha lo scopo di esprimere, mediante l'accordo delle voci, l'unione spirituale di coloro che si comunicano, dimostrare la gioia del cuore e rendere più fraterna la processione di coloro che si accostano a ricevere il corpo di Cristo. Il canto comincia mentre il sacerdote si comunica, e si protrae per un certo tempo, durante la comunione dei fedeli. Se però è previsto che dopo la comunione si eseguisca un inno, il canto di comunione s'interrompa al momento opportuno. Come canto di comunione si può utilizzare quello dell'antifonale, con o senza salmo, oppure un altro canto adatto, secondo le norme date per il canto d'ingresso (cfr. n. 26). Se non viene cantato sia recitato.
j) Ultimata la distribuzione della comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità, pregano per un po' di tempo in silenzio. Si può anche far cantare da tutta l'assemblea un inno, un salmo o un altro canto di lode.
k) Nell'orazione dopo la comunione, il sacerdote chiede i frutti del mistero celebrato. Il popolo fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen.
D) RITI DI CONCLUSIONE
58. I riti di conclusione comprendono:
a) Il saluto e la benedizione del sacerdote, che in alcuni giorni e in certe circostanze si può arricchire e sviluppare con un'altra formula più solenne.
b) Il congedo propriamente detto, con il quale si scioglie l'assemblea, perché ognuno ritorni alle sue occupazioni lodando e benedicendo il Signore.
1.Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 5; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 33.
2.Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, cap. 1; Cfr. Paolo VI, Solenne professione di fede, 30 giugno 1968, n. 24; AAS 60 (1967) p. 442.
3.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 7; Cfr. Paolo VI, Lettera enciclica Mysterium Fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) p. 764; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 9: AAS 59 (1967) p. 547.
4.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 56; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 10: AAS 59 (1967) p. 547.
5.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 48-51; Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Divina rivelazione Dei Verbum, n. 21; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 4.
6.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33, 52.
7.Cfr. Ibidem, n. 33.
8.Cfr. Sacra Congregazione per il Culto Divino, Lettera circolare sulle Preci eucaristiche, 27 aprile 1973, n. 14: AAS 65 (1973) p. 346.
9.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 14: AAS 59 (1967) p. 304.
10.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn. 26, 27; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 3d: AAS 59 (1967) p. 542.
11.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30.
12.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 16a: AAS 59 (1967) p. 305.
13.Sermo 336,1: PL 38,1472.
14.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, nn. 7, 16: AAS 59 (1967) pp. 302, 305; cfr. Messale Romano, Ordo cantus Missae, ed. tipica 1972, Premesse.
15.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 54; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 59: AAS 56 (1964) p. 891; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam Sacram, 5 marzo 1967, n. 47: AAS 59 (1967) p. 314.
16.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30.
17.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30.
18.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 30; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam Sacram, 5 marzo 1967, n. 17: AAS 59 (1967) p. 305.
19.Cfr. Ibidem, n. 7.
20.Cfr. Ibidem, n. 51.
21.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 50: AAS 56 (1964) p. 889.
22.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 52.
23.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 54: AAS 56 (1964) p. 890.
24.Cfr. Ibidem, n. 53.
25.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) p. 898; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) p. 554.
26.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 53.
27.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 56: AAS 56 (1964) p. 890.
28.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 47; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 3a, b: AAS 59 (1967) p. 540-541.
29.Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 48; Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 5; Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Mysterium, 25 maggio 1967, n. 12: AAS 59 (1967) p. 548-549.
30.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Nysterium, 25 maggio 1967, nn. 12, 33a: AAS 59 (1967) pp. 549, 559.
31.Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum Nysterium, 25 maggio 1967, nn. 31, 32: AAS 59 (1967) pp. 558-559; sulla facoltà di comunicarsi due volte nel medesimo giorno cfr. CIC, can. 917.
Ultima modifica di enricorns2 il Gio Set 08, 2016 11:53 pm - modificato 1 volta.